L’indomito domandare e la tenera attesa: il Vangelo secondo Pasolini
L’indomito domandare e la tenera attesa: il Vangelo secondo Pasolini
« Il miglior film su Cristo, per me, è Il Vangelo secondo Matteo, di Pasolini. Quando ero giovane, volevo fare una versione contemporanea della storia di Cristo ambientata nelle case popolari e per le strade del centro di New York. Ma quando ho visto il film di Pasolini, ho capito che quel film era già stato fatto. »
(Martin Scorsese, intervista a La Civiltà Cattolica, quaderno 3996, 24 dicembre 2016.)
Le definizioni sono- per inesorabile destino- di grande utilità pratica ma anche troppo semplici per qualsiasi cosa e per qualsiasi circostanza. Ciò vale a maggior ragione per le opere senza tempo, quelle che a distanza di decenni mozzano ancora il fiato per espressività e spunti estetici sorprendentemente attuali. Nell’ ambito della cinematografia italiana, Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini occupa senza dubbio un posto particolare, per innumerevoli motivi, non ultimi i riconoscimenti tardivi che la pellicola ha conosciuto nel corso degli anni, ma anche per il valore che fin dagli inizi è stato notato dalla critica attenta e scevra da pregiudizi. Il film è ammutolente, nel senso che induce al silenzio meditativo dell’incontro con qualcosa di sconvolgente, un’effetto che Pasolini riesce a sortire attingendo a tutta l’espressività di cui è capace, sfoderando una gamma di tagli chiaroscurali decisi, che lasciano sbigottiti per come affondano nella psicologia dello spettatore.  Diretta nel 1964, la pellicola indugia in una chiave di lettura assolutamente non oleografica, contribuendo alla ripresa delle non del tutto dissipate polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi di censura che avevano condizionato l’uscita dell’episodio de La ricotta, inserito nel film Ro.Go.Pa.G., riproponendo in maniera fedele Il Vangelo di Matteo della vita di Gesù Cristo: dall’annunciazione a Maria della nascita del figlio di Dio, al matrimonio con Giuseppe e la fuga in Egitto per sfuggire ad Erode ed alla strage degli innocenti, dagli inizi della predicazione, alle prove nel deserto, dai miracoli fino al processo presieduto da Ponzio Pilato, dalla condanna alla crocifissione fino alla resurrezione. Un’opera che presenta vicende realizzative anch’esse assai curiose, che vale la pena ricordare e che probabilmente contribuiscono a ricomporre il quadro generale dell’opera ai fini di un vaglio critico.
Diretta nel 1964, la pellicola indugia in una chiave di lettura assolutamente non oleografica, contribuendo alla ripresa delle non del tutto dissipate polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi di censura che avevano condizionato l’uscita dell’episodio de La ricotta, inserito nel film Ro.Go.Pa.G., riproponendo in maniera fedele Il Vangelo di Matteo della vita di Gesù Cristo: dall’annunciazione a Maria della nascita del figlio di Dio, al matrimonio con Giuseppe e la fuga in Egitto per sfuggire ad Erode ed alla strage degli innocenti, dagli inizi della predicazione, alle prove nel deserto, dai miracoli fino al processo presieduto da Ponzio Pilato, dalla condanna alla crocifissione fino alla resurrezione. Un’opera che presenta vicende realizzative anch’esse assai curiose, che vale la pena ricordare e che probabilmente contribuiscono a ricomporre il quadro generale dell’opera ai fini di un vaglio critico.
Il motivo del film e le vicissitudini della produzione: la casuale lettura del vangelo da parte di Pasolini
L’idea de Il Vangelo secondo Matteo ha davvero risvolti singolari, poco noti, ma che strappano anche qualche sorriso compiaciuto a chi poi ne viene a conoscenza. Il tutto nasce dalle solite impronosticabili uscite di Pasolini, spesso avvezzo a fughe solitarie per i vari luoghi dell’Italia. In una di queste, il caso o il destino volle che un giorno Pasolini arrivasse ad Assisi quasi senza volerlo coscientemente. In quel luogo giunse il 2 ottobre 1962, proprio lì si ricordò che circa un mese prima aveva ricevuto un invito per partecipare a un convegno di cineasti indetto dalla Pro Ci- vitate christiana. Ma la storia ci dice che a quell’ invito Pasolini avesse risposto in modo infastidito, non sopportando notoriamente gli atteggiamenti farisaici di chi-ai suoi occhi-non rivelava una coerenza fra le intenzioni religiose e una condotta esattamente contraria ad esse. Sempre il caso o il destino volle che quel giorno ci fosse proprio papa Giovanni XXIII, motivo per il quale Pasolini decise di non sovrapporsi alla massima autorità del cattolicesimo romano, preferendo andare alla Cittadella della Pro Civitate, dove prese una stanza. Allungando involontariamente la mano sul comodino, prese il libro dei Vangeli, iniziando a leggerlo dall’ inizio, cioè dal vangelo di Matteo. Quel giorno nacque, di fatto, il film.  L’idea di un film ispirato al testo di Matteo si era venuta sviluppando nella sua interiorità al punto che non poté più arginare il bisogno di comunicare a qualcuno questa sua clamorosa scelta. Pasolini, dunque, ne parlò con il fondatore della Pro Civitate, don Giovanni Rossi, che a sua volta incaricò una persona fidata di seguire il progetto: Lucio Caruso, giovane volontario della Pro Civitate, con trascorsi umanitari in Africa. Del progetto è informato chiaramente Alfredo Bini, il produttore dello scrittore, personaggio arguto ed erudito, che intuisce il potenziale di provocazione culturale dell’idea di Pasolini, ma anche la necessità di un via libera della Chiesa cattolica, soprattutto dopo le polemiche che hanno visto proprio Pasolini più volte processato per vilipendio alla religione. Pasolini è ben cosciente del fatto e si rivolge ancora a Lucio Caruso. A partire dal febbraio 1963 le sue visite alla Cittadella si fanno sempre più frequenti, mentre fra il 27 giugno e l’11 luglio 1963 Pasolini effettua un sopralluogo in quella parte di Palestina che fu testimone delle vicende terrene di Gesù Cristo, avvalendosi anche della consulenza di don Andrea Carraro, un esperto biblista. Quel viaggio avrà come esito un documentario straordinario: Itinerari evangelici in Palestina. Al suo ritorno, il regista deve solo superare un ultimo ostacolo: un sì del Vaticano. A questo punto della vicenda, compare un deus ex machina: il pugnace don Francesco Angelicchio, che tre anni prima nel 1960, era stato nominato, direttamente da papa Giovanni XXIII, consulente ecclesiastico del Centro cattolico cinematografico, vantando anche un passato addirittura nella Resistenza. Fu proprio questo prete che più volte si recò in segreteria di Stato a perorare la causa del film. Terminate le riprese de Il Vangelo secondo Matteo, don Francesco gli fece notare di aver tralasciato i miracoli di Gesù Cristo, a cominciare dal più grande: la risurrezione. Di conseguenza Pasolini tornò sul set e decise di girare le scene mancanti. Si arrivò così alla presentazione del film all’ edizione 1964 della mostra di Venezia, che si concluse con un autentico trionfo: il film conquistò infatti il Gran Premio della giuria, il riconoscimento della critica internazionale e dell’Ocic (Office catholique international du cinéma).
L’idea di un film ispirato al testo di Matteo si era venuta sviluppando nella sua interiorità al punto che non poté più arginare il bisogno di comunicare a qualcuno questa sua clamorosa scelta. Pasolini, dunque, ne parlò con il fondatore della Pro Civitate, don Giovanni Rossi, che a sua volta incaricò una persona fidata di seguire il progetto: Lucio Caruso, giovane volontario della Pro Civitate, con trascorsi umanitari in Africa. Del progetto è informato chiaramente Alfredo Bini, il produttore dello scrittore, personaggio arguto ed erudito, che intuisce il potenziale di provocazione culturale dell’idea di Pasolini, ma anche la necessità di un via libera della Chiesa cattolica, soprattutto dopo le polemiche che hanno visto proprio Pasolini più volte processato per vilipendio alla religione. Pasolini è ben cosciente del fatto e si rivolge ancora a Lucio Caruso. A partire dal febbraio 1963 le sue visite alla Cittadella si fanno sempre più frequenti, mentre fra il 27 giugno e l’11 luglio 1963 Pasolini effettua un sopralluogo in quella parte di Palestina che fu testimone delle vicende terrene di Gesù Cristo, avvalendosi anche della consulenza di don Andrea Carraro, un esperto biblista. Quel viaggio avrà come esito un documentario straordinario: Itinerari evangelici in Palestina. Al suo ritorno, il regista deve solo superare un ultimo ostacolo: un sì del Vaticano. A questo punto della vicenda, compare un deus ex machina: il pugnace don Francesco Angelicchio, che tre anni prima nel 1960, era stato nominato, direttamente da papa Giovanni XXIII, consulente ecclesiastico del Centro cattolico cinematografico, vantando anche un passato addirittura nella Resistenza. Fu proprio questo prete che più volte si recò in segreteria di Stato a perorare la causa del film. Terminate le riprese de Il Vangelo secondo Matteo, don Francesco gli fece notare di aver tralasciato i miracoli di Gesù Cristo, a cominciare dal più grande: la risurrezione. Di conseguenza Pasolini tornò sul set e decise di girare le scene mancanti. Si arrivò così alla presentazione del film all’ edizione 1964 della mostra di Venezia, che si concluse con un autentico trionfo: il film conquistò infatti il Gran Premio della giuria, il riconoscimento della critica internazionale e dell’Ocic (Office catholique international du cinéma).
Un attore sindacalista attorniato da intellettuali e persone comuni
La scelta di Pasolini di tratteggiare un Cristo “poco cattolico”, almeno secondo l’immaginario e l’iconografia comune, lo conduce-al giudizio di chi scrive-ad una visione paradossalmente più vicina al verosimile. Se, stando alle cronache religiose, Gesù Cristo era praticamente un palestinese, buon senso suggerisce che non vantasse occhi cerulei e fluente chioma bionda o castano-chiaro, come poi la versione di Zeffirelli quasi quindici anni più tardi contribuì a fissare quasi indelebilmente nelle menti del pubblico. Pasolini con questo film dimostra di aver imparato la lezione di geografia.  Ma soprattutto, intuisce la natura tormentata del Cristo, la sua indomabile natura di asceta sempre pronto all’ azione sincera e clamorosa contro l’ipocrisia del mondo. Un Cristo insomma anche da questo punto di vista lontanissimo anni-luce da quello concepito da Zeffirelli, che, seppur interpretato dal valente Robert Powell, appare sempre inchiavardato ad atteggiamenti lacrimevoli e compassati, ad una gestualità a volte ingessata o comunque affettata. Il Cristo pasoliniano è un concentrato di dinamite esplosiva e sentenziosità tagliente, ha il piglio del guerriero e la brillantezza oratoria di un capo-popolo. D’altra parte, questo film celebra proprio il riscatto gentile degli sfruttati: i piani sequenza durante la predicazione del figlio di Dio, balzano agli occhi come i ritratti commoventi di un pittore come Antonio Mancini, celebre autore di un quadro formidabile come Prevetariello. Ma senza scomodare i paragoni con la storia dell’arte, si può molto più immediatamente riferirsi ai quartieri popolari del Sud d’Italia proprio di quegli anni, di quei bambini dall’infanzia mancata, costretti a marinare la scuola per lavorare ai fini del mantenimento della famiglia d’origine. Sono i bambini della Napoli post-bellica delle zone di Forcella, del rione Sanità a Napoli, di quartieri come lo Zen, il Cep a Palermo, oppure della Bari vecchia di qualche decennio fa. Se si tengono conto di queste considerazioni, si comprende agevolmente come la scelta di Pasolini dell’attore protagonista dovesse cadere sull’ allora sconosciuto catalano Enrique Irazoqui allora sindacalista diciannovenne, in Italia per cercare appoggi alla lotta contro il regime franchista, doppiato nel film da Enrico Maria Salerno. Di estrazione borghese, di padre spagnolo e madre italiana originaria di Salò, Irazoqui diviene sin da giovane un militante comunista e antifranchista che nel febbraio del 1964, all’età di 19 anni, è inviato dal sindacato universitario clandestino di Barcellona, di cui faceva parte, in Italia per cercare appoggi tra i grandi della cultura italiana, allo scopo di portarli in Spagna a tenere conferenze contro la dittatura nelle università.
Ma soprattutto, intuisce la natura tormentata del Cristo, la sua indomabile natura di asceta sempre pronto all’ azione sincera e clamorosa contro l’ipocrisia del mondo. Un Cristo insomma anche da questo punto di vista lontanissimo anni-luce da quello concepito da Zeffirelli, che, seppur interpretato dal valente Robert Powell, appare sempre inchiavardato ad atteggiamenti lacrimevoli e compassati, ad una gestualità a volte ingessata o comunque affettata. Il Cristo pasoliniano è un concentrato di dinamite esplosiva e sentenziosità tagliente, ha il piglio del guerriero e la brillantezza oratoria di un capo-popolo. D’altra parte, questo film celebra proprio il riscatto gentile degli sfruttati: i piani sequenza durante la predicazione del figlio di Dio, balzano agli occhi come i ritratti commoventi di un pittore come Antonio Mancini, celebre autore di un quadro formidabile come Prevetariello. Ma senza scomodare i paragoni con la storia dell’arte, si può molto più immediatamente riferirsi ai quartieri popolari del Sud d’Italia proprio di quegli anni, di quei bambini dall’infanzia mancata, costretti a marinare la scuola per lavorare ai fini del mantenimento della famiglia d’origine. Sono i bambini della Napoli post-bellica delle zone di Forcella, del rione Sanità a Napoli, di quartieri come lo Zen, il Cep a Palermo, oppure della Bari vecchia di qualche decennio fa. Se si tengono conto di queste considerazioni, si comprende agevolmente come la scelta di Pasolini dell’attore protagonista dovesse cadere sull’ allora sconosciuto catalano Enrique Irazoqui allora sindacalista diciannovenne, in Italia per cercare appoggi alla lotta contro il regime franchista, doppiato nel film da Enrico Maria Salerno. Di estrazione borghese, di padre spagnolo e madre italiana originaria di Salò, Irazoqui diviene sin da giovane un militante comunista e antifranchista che nel febbraio del 1964, all’età di 19 anni, è inviato dal sindacato universitario clandestino di Barcellona, di cui faceva parte, in Italia per cercare appoggi tra i grandi della cultura italiana, allo scopo di portarli in Spagna a tenere conferenze contro la dittatura nelle università. Nel suo viaggio italiano conosce Pietro Nenni, Giorgio La Pira, Vasco Pratolini, Giorgio Bassani, Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini. Nonostante, poi con quest’ultimo avesse instaurato un ottimo rapporto personale, all’inizio fa resistenza all’ipotesi che sia lui a interpretare il Cristo nel film. Il motivo dell’iniziale rifiuto è appunto l’ideologia del giovane, per cui il giovane Enrique è convinto ad accettare proprio da Pier Paolo Pasolini, ma anche da Elsa Morante, dal produttore Alfredo Bini e dall’amico Giorgio Manacorda. La strategia di convincimento passa attraverso due espedienti: il suggerimento di fargli interpretare un Gesù “rosso”, dai marcati toni gramsciano-popolari e di sinistra; la dimostrazione che la paga che avrebbe ricevuto sarebbe stata un’ottima occasione per sostenere economicamente la causa del movimento clandestino antifranchista (alla quale difatti successivamente Irazouqui devolverà il compenso artistico). Ma dopo l’esperienza filmica con Pasolini la sua vita diventa ancora più avventurosa, perché rientrato successivamente in Spagna, è punito dal regime franchista per aver partecipato alla realizzazione di un film di “propaganda comunista”, e dopo ancora nel periodo compreso fra il 1969 al 1972 a Parigi, studia e si laurea in Economia, iniziando anche a lavorare a capo di un’azienda.
Nel suo viaggio italiano conosce Pietro Nenni, Giorgio La Pira, Vasco Pratolini, Giorgio Bassani, Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini. Nonostante, poi con quest’ultimo avesse instaurato un ottimo rapporto personale, all’inizio fa resistenza all’ipotesi che sia lui a interpretare il Cristo nel film. Il motivo dell’iniziale rifiuto è appunto l’ideologia del giovane, per cui il giovane Enrique è convinto ad accettare proprio da Pier Paolo Pasolini, ma anche da Elsa Morante, dal produttore Alfredo Bini e dall’amico Giorgio Manacorda. La strategia di convincimento passa attraverso due espedienti: il suggerimento di fargli interpretare un Gesù “rosso”, dai marcati toni gramsciano-popolari e di sinistra; la dimostrazione che la paga che avrebbe ricevuto sarebbe stata un’ottima occasione per sostenere economicamente la causa del movimento clandestino antifranchista (alla quale difatti successivamente Irazouqui devolverà il compenso artistico). Ma dopo l’esperienza filmica con Pasolini la sua vita diventa ancora più avventurosa, perché rientrato successivamente in Spagna, è punito dal regime franchista per aver partecipato alla realizzazione di un film di “propaganda comunista”, e dopo ancora nel periodo compreso fra il 1969 al 1972 a Parigi, studia e si laurea in Economia, iniziando anche a lavorare a capo di un’azienda.  Tuttavia, anche questo ruolo, però, è in contrasto con la sua ideologia, per cui sentendosi non gratificato, lascia il lavoro dopo solo cinque mesi. Successivamente ancora, negli Stati Uniti, prende una seconda laurea in Letteratura spagnola e nel 1976 inizia ad insegnare questa materia nelle università statunitensi. Quello che è stato il volto del Cristo pasoliniano, è passato alla storia anche per un altro particolare: Enrique Irazoqui è stato ed è un grandissimo scacchista, poiché sin da bambino diventa un competente giocatore, riuscendo persino a battere, nel 1968, Marcel Duchamp, numero tre della squadra olimpica francese. L’Italia gli è rimasta nel cuore, al punto che nel giugno del 2011 torna in Italia per andare a Matera, invitato per una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini, e in quella occasione riceve la cittadinanza onoraria dalla città. Lontano anche dalle aule universitarie, da anni vive a Cadaqués, cittadina diventata famosa per i tornei di scacchi da lui organizzati tra campioni, come Vladimir Kramnik, contro i computer, e per essere stato soggiorno di artisti come Salvador Dalí, Pablo Picasso e Federico García Lorca. Accanto a questo attore all’epoca sconosciuto ma eccezionale per intensità e interpretazione, fanno la loro comparsa attori scelti fra la popolazione locale contadina, volti anonimi eppure indimenticabili, perché quasi scolpiti nella pietra, cui poteva anche mancare la parola per l’espressività delle fattezze, gli sguardi scrutatori, le bocche serrate. Veri e proprio attori candidabili per un grandissimo film muto, uomini e donne che non si esclude potessero piacere ad un Carl Theodor Dreyer, indimenticabile autore de La passione di Giovanna D’Arco, un gioiello immortale della cinematografia muta. Che dire poi del vezzo di Pasolini di far coesistere questi sconosciuti con alcuni intellettuali di fama come Natalia Ginzburg, Alfonso Gatto ed Enzo Siciliano, oltre al solito Ninetto Davoli? Una genialata: un gioco meta-artistico dove Pasolini metaforizza la commistione fra cultura alta e cultura bassa, attraverso la fusione di un cast impensabile per qualsiasi regista dell’epoca e forse anche di oggi. Una considerazione a parte la merita la scelta di Pasolini di far recitare la madre Susanna per interpretare la Madonna anziana. Qui-lo si afferma con sincerità e senza esagerazione-siamo di fronte ad una sorta di premonizione, se si pensa al semplice fatto che quando nel novembre del 1975 Pasolini verrà barbaramente ucciso, proprio lui-stando alla testimonianza di Pino Pelosi- invocherà, morente, l’amatissima madre.
Tuttavia, anche questo ruolo, però, è in contrasto con la sua ideologia, per cui sentendosi non gratificato, lascia il lavoro dopo solo cinque mesi. Successivamente ancora, negli Stati Uniti, prende una seconda laurea in Letteratura spagnola e nel 1976 inizia ad insegnare questa materia nelle università statunitensi. Quello che è stato il volto del Cristo pasoliniano, è passato alla storia anche per un altro particolare: Enrique Irazoqui è stato ed è un grandissimo scacchista, poiché sin da bambino diventa un competente giocatore, riuscendo persino a battere, nel 1968, Marcel Duchamp, numero tre della squadra olimpica francese. L’Italia gli è rimasta nel cuore, al punto che nel giugno del 2011 torna in Italia per andare a Matera, invitato per una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini, e in quella occasione riceve la cittadinanza onoraria dalla città. Lontano anche dalle aule universitarie, da anni vive a Cadaqués, cittadina diventata famosa per i tornei di scacchi da lui organizzati tra campioni, come Vladimir Kramnik, contro i computer, e per essere stato soggiorno di artisti come Salvador Dalí, Pablo Picasso e Federico García Lorca. Accanto a questo attore all’epoca sconosciuto ma eccezionale per intensità e interpretazione, fanno la loro comparsa attori scelti fra la popolazione locale contadina, volti anonimi eppure indimenticabili, perché quasi scolpiti nella pietra, cui poteva anche mancare la parola per l’espressività delle fattezze, gli sguardi scrutatori, le bocche serrate. Veri e proprio attori candidabili per un grandissimo film muto, uomini e donne che non si esclude potessero piacere ad un Carl Theodor Dreyer, indimenticabile autore de La passione di Giovanna D’Arco, un gioiello immortale della cinematografia muta. Che dire poi del vezzo di Pasolini di far coesistere questi sconosciuti con alcuni intellettuali di fama come Natalia Ginzburg, Alfonso Gatto ed Enzo Siciliano, oltre al solito Ninetto Davoli? Una genialata: un gioco meta-artistico dove Pasolini metaforizza la commistione fra cultura alta e cultura bassa, attraverso la fusione di un cast impensabile per qualsiasi regista dell’epoca e forse anche di oggi. Una considerazione a parte la merita la scelta di Pasolini di far recitare la madre Susanna per interpretare la Madonna anziana. Qui-lo si afferma con sincerità e senza esagerazione-siamo di fronte ad una sorta di premonizione, se si pensa al semplice fatto che quando nel novembre del 1975 Pasolini verrà barbaramente ucciso, proprio lui-stando alla testimonianza di Pino Pelosi- invocherà, morente, l’amatissima madre.
La riscoperta del Sud che recita insieme agli attori
Fra i tanti aspetti del film che meritano di essere rimarcati, vi è la scelta dell’ambientazione delle vicende narrate. Un aspetto che non si spiega con esigenze freddamente scenografiche, ma che rivela la presenza di un messaggio profondo che Pasolini intende lanciare all’ intera civiltà occidentale. In una fase storica nella quale l’Italia borghese e piccolo-borghese conosce i frutti post-bellici del consumo di massa, l’esplodere della spensieratezza del boom economico, fatta di frigoriferi e nuove forme di intrattenimento, l’arretratezza del sud appare come un problema di cui non parlare troppo, da accantonare come la polvere sotto il tappeto, un luogo da “coprire”. All’epoca dei governi democristiani, qualche autorità politica parlò di “Matera, vergogna d’Italia”, a conferma delle difficoltà di affrontare questioni che già con l’unità d’Italia avrebbero meritato ben altre risposte sociali. Pasolini, invece, ritraendo questa città della Basilicata, ne aveva già intravisto all’epoca il fascino ieratico delle gravine, la sua naturale conformazione geologica votata a custodire quel “sacro” messo al bando dalla civiltà del progresso: un modo elegante e silenzioso per dirci che se “Dio è in ogni luogo”, questo valeva anche e soprattutto per Matera. Se si pensa poi che al 1964 risale uno scritto del filosofo francese di orientamento cattolico Gabriel Marcel, intitolato Il sacro nell’età della tecnica, s’intuisce come Pasolini fosse anche a sua stessa insaputa nel pieno di un dibattito culturale di altissimo livello, incardinato su questioni antropologiche cruciali e ben al di là dell’opinionismo politico-ideologico, cui tuttavia non mancava di spiccare per l’originalità delle sue posizioni. Forse, lo stesso riconoscimento a più di 50 anni di distanza a questa città della Basilicata di “Città della cultura” nel gennaio 2019, appare come una delle tante premonizioni pasoliniane, all’epoca passata praticamente sotto il più completo silenzio. Ma non vi è solo Matera e le sue gravine a recitare nel film di Pasolini, bensì tante altre località meridionali, di cui si perdono le inevitabili differenze grazie ad un montaggio lirico capace di sfumarle l’una nell’altra: il cortile interno del Castello di Gioia del Colle, location per la danza di Salomè; Barile e Lagopesole (la scena del sinedrio è girata nel cortile interno del Castello di Lagopesole), i Sassi di Matera (trasformati in Gerusalemme);la Calabria, in particolare a Cutro e Le Castella; il Lazio, in particolare a Chia (frazione di Soriano nel Cimino, Viterbo); la Puglia, in particolare a Ginosa nella Gravina, Massafra (trasformata in alcuni luoghi della Palestina), Manduria, Castel del Monte (la cacciata dal tempio, con i sacerdoti che assistono agli eventi), Gioia del Colle (in quest’ultima località il regista girò l’episodio di Erode e Salomè, ambientato nel castello, con la danza di Salomè che si svolge nell’ala nord della corte del castello stesso), Santeramo in Colle (l’annunciazione, parte del discorso delle beatitudini, l’avvicinamento a Gerusalemme);la Sicilia, in particolare la valle dell’Etna (tentazioni nel deserto). Basterebbe questa sequenza di località, ricattate artisticamente dalle intuizione di Pasolini, per parlare di una sintonia evidente fra il regista e il sud negletto dell’Italia prossima ventura votata al consumismo. Eppure, è doveroso rimarcare ancora un altro elemento che dimostra la capacità di Pasolini di guardare il sud “dal di dentro”: la sottolineatura musicale di alcune scene (con protagonisti poveri, sfruttati e derelitti) con brani blues-gospel. Una trovata che appare anticipare quanti nella musica degli anni settanta e ottanta in Europa e in Italia hanno parlato di “world music”, di aree geografiche lontane ma accomunate dalla stessa sensibilità musicale, in una parola: dei tanti “sud” che si trovano uniti in una grande, immensa anima sonora. Un’ altro, stupefacente particolare che contribuisce a distanza di decenni di avere un quadro più completo di questa pellicola cinematografica e del suo quasi inesauribile significato estetico.
Valore dell’opera
Sulla religiosità inconfessata o inconsapevole di Pasolini molto si è scritto e spesso con giudizi poco sereni. Se da una parte, infatti, lo scrittore di Ragazzi di vita è stato il bersaglio preferito della frange politiche della destra più bigotta e più o meno apertamente fascista, dall’altra non si deve tacere la diffidenza con cui è stato sempre considerato non solo dagli organi del Partito Comunista italiano, nonché da esponenti ufficiali della cultura marxista, spesso operanti nel campo della critica letteraria. Si pensi, ad esempio, alle divergenze dichiarate di un letterato come Edoardo Sanguineti nei confronti proprio di Pasolini su temi come il passato contadino e di come esso debba essere considerato. Rimane il fatto che questo Vangelo secondo Matteo esprime tutto il fascino che la figura del Cristo esercita su un ateo/agnostico come Pasolini, che rivela, suo malgrado, di essere sospeso nelle orbite della ricerca di un Sacro “deconfessionalizzato”, spoglio delle sovrastrutture ipocrite della religione troppo incline alla gestione del mondo e quindi “desacralizzata”. Un film per non credenti, certamente. Ma anche un film per pseudo-credenti, per quanti s’impigriscono in una visione troppo consolatoria del Cristo, annacquando la tensione struggente fra umano e divino che la sintesi cristica ha tragicamente rappresentato per l’intera umanità. Per questo è stuzzicante pensare che in soccorso di Pasolini, corra papa Benedetto XVI(per tutti papa Ratzinger) che qualche anno fa dichiarò che gli atei autentici e in buona fede fossero più vicini a Dio di quanto non lo siano i falsi credenti. Una rassicurazione efficace per quanti, appunto, confidano più nel papa che nel Cristo.



 Ciò è l’elemento che secondo l’autore affratella Giacomo Noventa a Carlo Rosselli, Aldo Capitini a Nicola Chiaromonte, Ivan Illich a Colin Ward, Isaiah Berlin, Cesare Garboli a Chistopher Lasch. La questione fondamentale cui ruotano queste pagine sapienti forse vale una vita intera, almeno di una di quelle dedicate alla ricerca di un senso: Chi è davvero il maestro? Un azzardo di risposta potrebbe tenere conto della necessità di non confondere il ruolo del maestro (spesso frutto della cooptazione di alcune cerchie di persone “accreditate” che reclutano nelle loro fila politico-istituzionali altri “maestri”) con la sua funzione (che si esplica semplicemente con un operato intellettuale che non necessariamente deve concludersi con il riconoscimento dell’ufficialità e tutta la cerimoniosità, oltre che il potere, e le glorie raccolte in vita). Una dicotomia, questa, che riproduce la distanza ad esempio fra i primi sofisti dell’antica Grecia e il loro fiero avversario Socrate: i primi impegnati sempre a ricordare alla comunità di riferimento di essere “maestri” di una sapienza che in realtà si riduceva ad un’arte oratoria spesso mistificante; il secondo assolutamente indifferente al “titolo”, impegnato a sfidare l’ingiustizia dei tribunali con il solo conforto dei propri strumenti razionali, oltre che a spiazzare i suoi malcapitati intercolutori, sempre usciti malconci dal confronto dialettico.
Ciò è l’elemento che secondo l’autore affratella Giacomo Noventa a Carlo Rosselli, Aldo Capitini a Nicola Chiaromonte, Ivan Illich a Colin Ward, Isaiah Berlin, Cesare Garboli a Chistopher Lasch. La questione fondamentale cui ruotano queste pagine sapienti forse vale una vita intera, almeno di una di quelle dedicate alla ricerca di un senso: Chi è davvero il maestro? Un azzardo di risposta potrebbe tenere conto della necessità di non confondere il ruolo del maestro (spesso frutto della cooptazione di alcune cerchie di persone “accreditate” che reclutano nelle loro fila politico-istituzionali altri “maestri”) con la sua funzione (che si esplica semplicemente con un operato intellettuale che non necessariamente deve concludersi con il riconoscimento dell’ufficialità e tutta la cerimoniosità, oltre che il potere, e le glorie raccolte in vita). Una dicotomia, questa, che riproduce la distanza ad esempio fra i primi sofisti dell’antica Grecia e il loro fiero avversario Socrate: i primi impegnati sempre a ricordare alla comunità di riferimento di essere “maestri” di una sapienza che in realtà si riduceva ad un’arte oratoria spesso mistificante; il secondo assolutamente indifferente al “titolo”, impegnato a sfidare l’ingiustizia dei tribunali con il solo conforto dei propri strumenti razionali, oltre che a spiazzare i suoi malcapitati intercolutori, sempre usciti malconci dal confronto dialettico. Ma soprattutto una dicotomia nella quale i secondi ( cioè i maestri in termini di funzione) rivelano di essere davvero importante per i posteri per motivo tanto semplice quanto arduo da inverare: la coincidenza fra professione intellettuale e vita reale, la coesistenza di pensiero e azione quotidiana. In una parola: l’esempio. Proprio questa dimensione esistenziale rende le figure esaminate da La Porta espressioni importanti di testimonianze intellettuali appunto “disorganiche”, cioè non assimilate o assimilabili al discorso omologate delle strutture di pensiero (siano esse politiche o accademiche), cui magari alcune di esse sentivano di appartenere. In questa disorganicità prende forma la qualità di un contributo culturale personale di ognuna di loro, che poi il corso del tempo ha dimostrato di rivalutare agli occhi e alla menti dei posteri.
Ma soprattutto una dicotomia nella quale i secondi ( cioè i maestri in termini di funzione) rivelano di essere davvero importante per i posteri per motivo tanto semplice quanto arduo da inverare: la coincidenza fra professione intellettuale e vita reale, la coesistenza di pensiero e azione quotidiana. In una parola: l’esempio. Proprio questa dimensione esistenziale rende le figure esaminate da La Porta espressioni importanti di testimonianze intellettuali appunto “disorganiche”, cioè non assimilate o assimilabili al discorso omologate delle strutture di pensiero (siano esse politiche o accademiche), cui magari alcune di esse sentivano di appartenere. In questa disorganicità prende forma la qualità di un contributo culturale personale di ognuna di loro, che poi il corso del tempo ha dimostrato di rivalutare agli occhi e alla menti dei posteri. 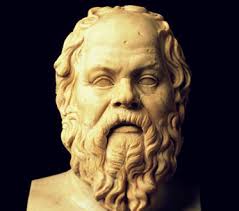 Così, con la discrezione di un gentleman della critica, La Porta fa avvertire la nostalgia per una stagione letteraria italiana e non solo nella quale era ancora possibile far tesoro dell’operato di intellettuali abili nell’essersi saputi smarcare dalle conventicole di partito o di accademia, dediti sempre alla vigile critica del presente, di cui erano sempre pronti a rintracciare i limiti oltre i quali non era conveniente andare, sempre sospinti da una passione destinata a travasarsi sempre negli altri, creandosi così un proprio spazio e un proprio pubblico, svolgendo cioè la funzione del maestro, lontani dal libro-paga di padroni( pubblici o privati) sempre pronti a dettare l’articolo o il libro di turno per il pubblico pagante e penosamente applaudente.
Così, con la discrezione di un gentleman della critica, La Porta fa avvertire la nostalgia per una stagione letteraria italiana e non solo nella quale era ancora possibile far tesoro dell’operato di intellettuali abili nell’essersi saputi smarcare dalle conventicole di partito o di accademia, dediti sempre alla vigile critica del presente, di cui erano sempre pronti a rintracciare i limiti oltre i quali non era conveniente andare, sempre sospinti da una passione destinata a travasarsi sempre negli altri, creandosi così un proprio spazio e un proprio pubblico, svolgendo cioè la funzione del maestro, lontani dal libro-paga di padroni( pubblici o privati) sempre pronti a dettare l’articolo o il libro di turno per il pubblico pagante e penosamente applaudente. Un saggio segnato da grande onestà intellettuale, se si pensa che oltre a denunciare la presa di posizione dei piemontesi in relazione al fenomeno del brigantaggio, ci si scrolla di dosso qualsiasi rischio di agiografia ultrameridionalista. Ciconte, infatti, denuncia la corruzione della rampante borghesia meridionale che approfittando del nuovo ordine politico post-borbonico ha di fatto tradito la causa politico-sociale del mezzogiorno, appiattendosi agli interessi della monarchia savoiarda. Un esempio su tutti è proprio il parlamentare abruzzese Pica, autore della famigerata legge militare che nel 1863 ha costituito l’unica risposta concreta e crudele al fenomeno del brigantaggio post-unitario: un neoparlamentare meridionale che risponde in quel modo ai problemi delle sue stesse zone di provenienza. Ma queste pagine storiche meritano una menzione particolare, soprattutto perché puntano ad un obiettivo fondamentale: chiarire una volta per tutte che i briganti non sono stati i “padri nobili”, gli “antenati illustri” dei mafiosi. Ciò è dimostrato dalla distribuzione geografica dei due fenomeni che, stando alle analisi dello storico calabrese, non conoscono una sovrapposizione per cui lì dove ci sono briganti non ci sono mafiosi e viceversa.
Un saggio segnato da grande onestà intellettuale, se si pensa che oltre a denunciare la presa di posizione dei piemontesi in relazione al fenomeno del brigantaggio, ci si scrolla di dosso qualsiasi rischio di agiografia ultrameridionalista. Ciconte, infatti, denuncia la corruzione della rampante borghesia meridionale che approfittando del nuovo ordine politico post-borbonico ha di fatto tradito la causa politico-sociale del mezzogiorno, appiattendosi agli interessi della monarchia savoiarda. Un esempio su tutti è proprio il parlamentare abruzzese Pica, autore della famigerata legge militare che nel 1863 ha costituito l’unica risposta concreta e crudele al fenomeno del brigantaggio post-unitario: un neoparlamentare meridionale che risponde in quel modo ai problemi delle sue stesse zone di provenienza. Ma queste pagine storiche meritano una menzione particolare, soprattutto perché puntano ad un obiettivo fondamentale: chiarire una volta per tutte che i briganti non sono stati i “padri nobili”, gli “antenati illustri” dei mafiosi. Ciò è dimostrato dalla distribuzione geografica dei due fenomeni che, stando alle analisi dello storico calabrese, non conoscono una sovrapposizione per cui lì dove ci sono briganti non ci sono mafiosi e viceversa. 
 Duplice è il valore di questo libro: il primo è di natura contenutistica, il secondo di natura stilistica. In relazione al primo aspetto, balza immediatamente all’attenzione l’enfasi che l’autore pone sulla nostalgia e la sua, spesso, non pienamente compresa positività per l’essere umano e il suo vissuto interiore. Da navigatissimo addetto ai lavori, Borgna conosce molto bene la pericolosità delle “spire” della nostalgia, che spesso come il più pericoloso dei pitoni, rischia di immobilizzarci al passato, pietrificando la vitalità del presente, letali, in ultima analisi, per la nostra integrità psichica.
Duplice è il valore di questo libro: il primo è di natura contenutistica, il secondo di natura stilistica. In relazione al primo aspetto, balza immediatamente all’attenzione l’enfasi che l’autore pone sulla nostalgia e la sua, spesso, non pienamente compresa positività per l’essere umano e il suo vissuto interiore. Da navigatissimo addetto ai lavori, Borgna conosce molto bene la pericolosità delle “spire” della nostalgia, che spesso come il più pericoloso dei pitoni, rischia di immobilizzarci al passato, pietrificando la vitalità del presente, letali, in ultima analisi, per la nostra integrità psichica. Mentre il primo traccia un rapporto fra noi e il passato come irrimediabile perdita, un valore non più recuperabile in alcun modo, una sorta di oggetto a noi molto caro che perdiamo per sempre nelle stive delle navi, il secondo, al contrario, anche nel ricordarci qualcosa che non c’è più, continua a farlo vivere dentro di noi, creando una sorta di canale di alimentazione, nel quale l’esperienza passata non è smarrita ma si rinnova di senso nel ricordo. Il rimpianto-afferma Borgna- si ricorda sempre e solo piangendo, consapevoli della nostra colpevolezza, quindi responsabilità diretta, di tale perdita-nella nostalgia(vitale) si ricorda con un sorriso agrodolce, qualcosa che potrebbe ancora avere un senso per lo stesso presente. Letta in questo modo la nostalgia nutre, nel mistero della repentinità del suo manifestarsi, l’interiorità umana, facendo in modo che essa, in qualche maniera, attinga senso, valore, vita dal passato. Una meditazione, questa di Borgna che si riallaccia inevitabilmente a quelle celebri del bergsoniano Proust mentre gusta anche solo l’odore della medelein, il dolce a cui sono state parole folgoranti ne La ricerca del tempo perduto, il tutto per evidenziare sempre che il passato è sempre dietro l’angolo della nostra anima, che pur essendo scomparso rappresenta sempre l’armadio da cui spunta l’indumento dimenticato.
Mentre il primo traccia un rapporto fra noi e il passato come irrimediabile perdita, un valore non più recuperabile in alcun modo, una sorta di oggetto a noi molto caro che perdiamo per sempre nelle stive delle navi, il secondo, al contrario, anche nel ricordarci qualcosa che non c’è più, continua a farlo vivere dentro di noi, creando una sorta di canale di alimentazione, nel quale l’esperienza passata non è smarrita ma si rinnova di senso nel ricordo. Il rimpianto-afferma Borgna- si ricorda sempre e solo piangendo, consapevoli della nostra colpevolezza, quindi responsabilità diretta, di tale perdita-nella nostalgia(vitale) si ricorda con un sorriso agrodolce, qualcosa che potrebbe ancora avere un senso per lo stesso presente. Letta in questo modo la nostalgia nutre, nel mistero della repentinità del suo manifestarsi, l’interiorità umana, facendo in modo che essa, in qualche maniera, attinga senso, valore, vita dal passato. Una meditazione, questa di Borgna che si riallaccia inevitabilmente a quelle celebri del bergsoniano Proust mentre gusta anche solo l’odore della medelein, il dolce a cui sono state parole folgoranti ne La ricerca del tempo perduto, il tutto per evidenziare sempre che il passato è sempre dietro l’angolo della nostra anima, che pur essendo scomparso rappresenta sempre l’armadio da cui spunta l’indumento dimenticato.  Per quanto riguarda il valore stilistico del libro, valgono le considerazioni seguenti. Il saggio si fa gustare per uno stile magnificamente limpido, un autentico distillato di erudizione, di cui solo i grandi scienziati sono capaci, maestri nell’ esercizio sublime della sentenza sferzante cui sarebbe un errore qualcosa in più. Eugenio Borgna, dunque, si sfila il camice ospedaliero e inforca la penna come lo potrebbe fare un Pietro Citati o la coppia Fruttero-Lucentini, onorando davvero l’aderenza al suo indirizzo teorico in ambito psichiatrico, ovvero quello fenomenologico-esistenziale, sciorinando riflessioni non in forma di diagnosi bensì di generose disamine di poesie eterne e di autori della levatura di Leopardi o Hugo di von Hofmannsthal, passando per la prosa avvolgente di Karen Blixen, indimenticata autrice de La mia africa, opera ripresa in un’omonima pellicola cult degli anni ’80 con una magistrale Meryline Streep e un altrettanto encomiabile Robert Redford. Proprio in relazione alle implicazioni del romanzo di questa autrice danese, vale la pena spendere qualche pensiero, in particolare circa la credibilità dell’esistenza di quello strano fenomeno chiamato “mal d’Africa”, la nostalgia per l’Africa, i suoi volti e i suoi paesaggi, uno stato d’animo di cui molte persone( più o meno note) hanno parlato nel corso della loro vita e a cui un vanto del cantautorato italiano, Franco Battiato, ha dedicato una delle sue più enigmatiche( e molto meno note) canzoni, intitolata Mal d’Africa( contenuta nell’album Orizzonti perduti) dove ai leoni e ai tramonti sulla Savana, si sostituiscono i fascinosi odori di brillantina con cui i padri siciliani pettinavano i loro capelli corvini oppure i cullanti “rumori di ringhiera”.
Per quanto riguarda il valore stilistico del libro, valgono le considerazioni seguenti. Il saggio si fa gustare per uno stile magnificamente limpido, un autentico distillato di erudizione, di cui solo i grandi scienziati sono capaci, maestri nell’ esercizio sublime della sentenza sferzante cui sarebbe un errore qualcosa in più. Eugenio Borgna, dunque, si sfila il camice ospedaliero e inforca la penna come lo potrebbe fare un Pietro Citati o la coppia Fruttero-Lucentini, onorando davvero l’aderenza al suo indirizzo teorico in ambito psichiatrico, ovvero quello fenomenologico-esistenziale, sciorinando riflessioni non in forma di diagnosi bensì di generose disamine di poesie eterne e di autori della levatura di Leopardi o Hugo di von Hofmannsthal, passando per la prosa avvolgente di Karen Blixen, indimenticata autrice de La mia africa, opera ripresa in un’omonima pellicola cult degli anni ’80 con una magistrale Meryline Streep e un altrettanto encomiabile Robert Redford. Proprio in relazione alle implicazioni del romanzo di questa autrice danese, vale la pena spendere qualche pensiero, in particolare circa la credibilità dell’esistenza di quello strano fenomeno chiamato “mal d’Africa”, la nostalgia per l’Africa, i suoi volti e i suoi paesaggi, uno stato d’animo di cui molte persone( più o meno note) hanno parlato nel corso della loro vita e a cui un vanto del cantautorato italiano, Franco Battiato, ha dedicato una delle sue più enigmatiche( e molto meno note) canzoni, intitolata Mal d’Africa( contenuta nell’album Orizzonti perduti) dove ai leoni e ai tramonti sulla Savana, si sostituiscono i fascinosi odori di brillantina con cui i padri siciliani pettinavano i loro capelli corvini oppure i cullanti “rumori di ringhiera”.  Una mirabolante composizione che Battiato nel lontanissimo 1983 dedicò alla nostalgia, con toni certamente più impegnativi e intellettuali rispetto all’analogo tentativo sanremese e canzonettistico del duo Al Bano e Romina intitolato Nostalgia canaglia, un pezzo che pure imperversò nei primi anni ottanta nelle radio nazionali. L’ausilio della parola poetica per parlare di psicologia, in ultima analisi, da parte di Borgna è anche una sorta di omaggio, non tanto implicito, alla letteratura e alla sua capacità di scrutare nel profondo dell’animo umano,cui la stessa scienza ufficiale non può non appellarsi allorquando esaurisce il suo vocabolario e avverte l’urgenza veicolare con efficacia certi messaggi. Fonti consultate per le immagini :
Una mirabolante composizione che Battiato nel lontanissimo 1983 dedicò alla nostalgia, con toni certamente più impegnativi e intellettuali rispetto all’analogo tentativo sanremese e canzonettistico del duo Al Bano e Romina intitolato Nostalgia canaglia, un pezzo che pure imperversò nei primi anni ottanta nelle radio nazionali. L’ausilio della parola poetica per parlare di psicologia, in ultima analisi, da parte di Borgna è anche una sorta di omaggio, non tanto implicito, alla letteratura e alla sua capacità di scrutare nel profondo dell’animo umano,cui la stessa scienza ufficiale non può non appellarsi allorquando esaurisce il suo vocabolario e avverte l’urgenza veicolare con efficacia certi messaggi. Fonti consultate per le immagini : 


 Andreotti, al contrario, non ha mai scimmiottato Luigi XIV, né ha ostentato la volontà di diventarlo, molto probabilmente in virtù della consapevolezza che il potere perdona tutto tranne una cosa: che il potere stesso sia posseduto da qualcuno. Lui era così: entrava dove voleva, sgattaiolando da una stanza all’altra, ma senza avere la presunzione di essere il proprietario del palazzo, piuttosto ne era l’abile custode, sempre ligio nell’ esercizio della chiave” giusta” per le porte da aprire, tirando fuori dalla sua gobba, come da un magico cilindro, soluzioni spiazzanti per chiunque. In più, aveva il dono della sintesi, di quella tipica delle sentenze veterotestamentarie o delle barzellette brevi, mai dimentico che il vero esercizio del potere non ha bisogno di tante parole. Nel film c’è una sequenza che vale un intero manuale per sordomuti. Ad un cero punto si spiega ad un interlocutore del presidente il significato della muta gestualità delle sue mani: se Andreotti gira i pollici, vuol dire che è d’accordo con quanto è stato detto; se si tocca la fede fra le dita, facendola roteare vuol dire che è in disaccordo, se inizia ad aprire le dita e a chiuderle facendo combaciare i polpastrelli l’uno contro l’altro, vuol dire che è in procinto di congedare senza appello il suo interlocutore. Insomma, l’Andreotti di Sorrentino e con il volto irriconoscibile di Servillo è imbarazzante per il livelli di realismo surreale che riesce a toccare. A prova di ciò si possono ricordare due elementi del film. Il primo è certamente più importante ed è il famoso monologo di quasi 2 minuti e mezzo, nel quale Andreotti-Servillo simula una confessione alla moglie, sviscerando tutte le responsabilità cui è sottoposto un uomo come lui: obbedire ad un’insondabile volontà di Dio per conservare il potere ed esercitarlo nelle sue forme più crudeli, in nome di una fedeltà che impone di non chiedere troppo circa la natura stessa della verità.
Andreotti, al contrario, non ha mai scimmiottato Luigi XIV, né ha ostentato la volontà di diventarlo, molto probabilmente in virtù della consapevolezza che il potere perdona tutto tranne una cosa: che il potere stesso sia posseduto da qualcuno. Lui era così: entrava dove voleva, sgattaiolando da una stanza all’altra, ma senza avere la presunzione di essere il proprietario del palazzo, piuttosto ne era l’abile custode, sempre ligio nell’ esercizio della chiave” giusta” per le porte da aprire, tirando fuori dalla sua gobba, come da un magico cilindro, soluzioni spiazzanti per chiunque. In più, aveva il dono della sintesi, di quella tipica delle sentenze veterotestamentarie o delle barzellette brevi, mai dimentico che il vero esercizio del potere non ha bisogno di tante parole. Nel film c’è una sequenza che vale un intero manuale per sordomuti. Ad un cero punto si spiega ad un interlocutore del presidente il significato della muta gestualità delle sue mani: se Andreotti gira i pollici, vuol dire che è d’accordo con quanto è stato detto; se si tocca la fede fra le dita, facendola roteare vuol dire che è in disaccordo, se inizia ad aprire le dita e a chiuderle facendo combaciare i polpastrelli l’uno contro l’altro, vuol dire che è in procinto di congedare senza appello il suo interlocutore. Insomma, l’Andreotti di Sorrentino e con il volto irriconoscibile di Servillo è imbarazzante per il livelli di realismo surreale che riesce a toccare. A prova di ciò si possono ricordare due elementi del film. Il primo è certamente più importante ed è il famoso monologo di quasi 2 minuti e mezzo, nel quale Andreotti-Servillo simula una confessione alla moglie, sviscerando tutte le responsabilità cui è sottoposto un uomo come lui: obbedire ad un’insondabile volontà di Dio per conservare il potere ed esercitarlo nelle sue forme più crudeli, in nome di una fedeltà che impone di non chiedere troppo circa la natura stessa della verità. L’ennesima lezione di un uomo potentissimo quanto normalissimo nel suo modo di presentarsi al mondo, nel suo immancabile distacco dalle cose, nel suo opportunismo che spesso si faceva beffe anche della stessa mediazione politica e che non poche volte si avvaleva di ammonimenti metaforici e minacciosi. “Io ho un diario”- amava ricordare quando doveva spegnere i fuochi pericolosi delle inchieste che potevano toccarlo. Si torna dunque alla questione di partenza: cos’ è allora il potere vero? Alla luce anche di questa pellicola di Sorrentino, si è indotti a pensare che esso sia qualcosa che si nasconde così bene da coincidere con la realtà quotidiana, che proprio per questo la controlla e per farlo non ha bisogno di mostrarsi più di quanto non lo facciano le posate, i bicchieri, i piatti che usiamo ogni giorno nel chiuso delle nostre stanze. Andreotti questo lo sapeva bene e ciò gli consentiva di ingoiare praticamente tutto, come un aspirapolvere che non si preoccupa di fare indigestione, grazie ad una conoscenza così capillare della realtà umana da non stupirsi praticamente di nulla. Un volto-il suo- che non è ingiurioso definire “banale” anzi se non lo fosse stato non sarebbe stato l’uomo di potere che tutti abbiamo conosciuto, esattamente come lo sono stati Rina e Provenzano che apparivano sempre come dei contadini indifesi, quando in realtà tenevano alle loro dipendenze uomini e capitali di quantità impensabili per qualunque latifondista.
L’ennesima lezione di un uomo potentissimo quanto normalissimo nel suo modo di presentarsi al mondo, nel suo immancabile distacco dalle cose, nel suo opportunismo che spesso si faceva beffe anche della stessa mediazione politica e che non poche volte si avvaleva di ammonimenti metaforici e minacciosi. “Io ho un diario”- amava ricordare quando doveva spegnere i fuochi pericolosi delle inchieste che potevano toccarlo. Si torna dunque alla questione di partenza: cos’ è allora il potere vero? Alla luce anche di questa pellicola di Sorrentino, si è indotti a pensare che esso sia qualcosa che si nasconde così bene da coincidere con la realtà quotidiana, che proprio per questo la controlla e per farlo non ha bisogno di mostrarsi più di quanto non lo facciano le posate, i bicchieri, i piatti che usiamo ogni giorno nel chiuso delle nostre stanze. Andreotti questo lo sapeva bene e ciò gli consentiva di ingoiare praticamente tutto, come un aspirapolvere che non si preoccupa di fare indigestione, grazie ad una conoscenza così capillare della realtà umana da non stupirsi praticamente di nulla. Un volto-il suo- che non è ingiurioso definire “banale” anzi se non lo fosse stato non sarebbe stato l’uomo di potere che tutti abbiamo conosciuto, esattamente come lo sono stati Rina e Provenzano che apparivano sempre come dei contadini indifesi, quando in realtà tenevano alle loro dipendenze uomini e capitali di quantità impensabili per qualunque latifondista.